Fondo per la Repubblica Digitale: con Prospettive+ 25 milioni per disoccupati e inattivi
Accrescere le competenze digitali di persone disoccupate e inattive (34 – 67 anni) per consentire la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro. Questo l’obiettivo di “Prospettive+” – seconda fase del bando “Prospettive” – promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale.
C’è tempo fino al 15 maggio 2026 per presentare progetti, attraverso il portale Re@dy da parte di enti del terzo settore, soggetti privati senza scopo di lucro e soggetti pubblici. Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti da un minimo di tre fino a un massimo di otto soggetti. Il bando mette a disposizione 25 milioni di euro e mira a sostenere progetti in grado di rafforzare le competenze digitali di persone disoccupate e inattive, tra i 34 e i 67 anni, al fine di consentirne la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro.
Per saperne di più partecipa ai due webinar di presentazione dell’iniziativa:
10 marzo, ore 15:00 | Iscriviti qui>
12 marzo, ore 11:30 | Iscriviti qui>
Info su fondorepubblicadigitale.it
Lo scale-up
Il Piano Strategico 2025-2026, delineato dal Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale, ha stabilito, infatti, la realizzazione dello scale-up di bandi già realizzati attraverso la pubblicazione di nuove opportunità aperte a tutti gli stakeholder interessati. In questo caso, i progetti già sostenuti nell’ambito di “Prospettive” che hanno dimostrato maggiore impatto nella fase sperimentale riceveranno una premialità per il nuovo bando. L’obiettivo di “Prospettive+” è sostenere – rispetto alla prima edizione – un numero limitato di progetti, di maggiori dimensioni in termini di risorse economiche assegnate, di beneficiari raggiunti e di raggruppamenti proponenti e consegnare al decisore pubblico le migliori pratiche in termini di efficacia e impatto generato.
Il contesto italiano
Secondo i più recenti dati Eurostat pubblicati a dicembre 2025, l’Italia registra un netto miglioramento rispetto alle competenze digitali: la quota di popolazione tra i 16 e i 74 anni con competenze digitalidi base sale dal 45,7% al 54,2%. Si tratta del secondo incremento più alto nell’UE, dopo la Danimarca, che consente al Paese di ridurre sensibilmente il divario con la media europea, pari a circa 60%. Nonostante il trend positivo, permangono ancora divari significativi che si accentuano con l’età e con il livello di istruzione: nella fascia 35–54 anni le competenze digitali di base riguardano il 78,3% dei laureati, ma solo il 25,7% di chi ha al massimo un titolo di istruzione secondaria inferiore, con effetti diretti sulle possibilità di rientro nel mercato del lavoro per chi è fuori dall’occupazione. La fragilità di disoccupati e inattivi è aggravata anche dalle disuguaglianze territoriali. I livelli più elevati di competenze digitali si registrano nella Provincia autonoma di Trento (56,8%), in Lombardia (53,4%), in Emilia-Romagna e nel Lazio (51,5%), mentre le percentuali più basse si osservano in Calabria (32,2%) e Campania (32,5%), ampliando il divario nelle opportunità di reinserimento lavorativo tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Nonostante la domanda di profili digitali sia in forte crescita – con oltre 222.000 annunci per professioni ICT nel biennio più recente e una quota di specialisti ICT pari al 4% degli occupati, contro il 5% della media UE – l’offerta di lavoratori adeguatamente formati resta insufficiente. Questo disallineamento si riflette anche nella struttura del lavoro esistente: solo il 37,1% degli occupati utilizza strumenti digitali per almeno metà del proprio tempo di lavoro, rispetto al 41,2% nella UE, indicando una diffusione ancora limitata delle competenze digitali nei contesti produttivi. In questo contesto, le carenze di competenze contribuiscono a rendere più difficile l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro, soprattutto per disoccupati e inattivi. Il quadro occupazionale conferma queste fragilità: a novembre 2025 il tasso di occupazione in Italia è pari al 62,6%, con un tasso di disoccupazione del 5,7% e una quota di inattivi ancora molto elevata, pari al 33,5% della popolazione in età lavorativa, con un’incidenza maggiore tra donne e adulti che non cercano attivamente un impiego.
A incidere negativamente è anche la partecipazione ancora limitata alla formazione continua: nel 2022 circa il 35,7% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha preso parte ad attività di lifelong learning, comprensive di formazione formale (corsi universitari o equivalenti) e non formale (corsi brevi, seminari, apprendimento sul lavoro), con una crescita stimata tra il 39% e il 41,5% nel 2024-2025 secondo dati INAPP ed Eurostat. Nonostante il progresso, il tasso resta inferiore all’obiettivo UE del 47% fissato per il 2025, riducendo le opportunità di aggiornamento soprattutto per disoccupati e inattivi, che rischiano di rimanere esclusi dai processi di innovazione e trasformazione produttiva. In questo scenario, investire nel rafforzamento delle competenze digitali delle persone disoccupate e inattive è una priorità strategica per aumentare l’occupabilità, favorire il reinserimento lavorativo e ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, contribuendo alla sostenibilità economica e sociale del Paese.
Cos’è il Fondo
Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità e cittadini. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.
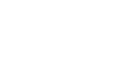




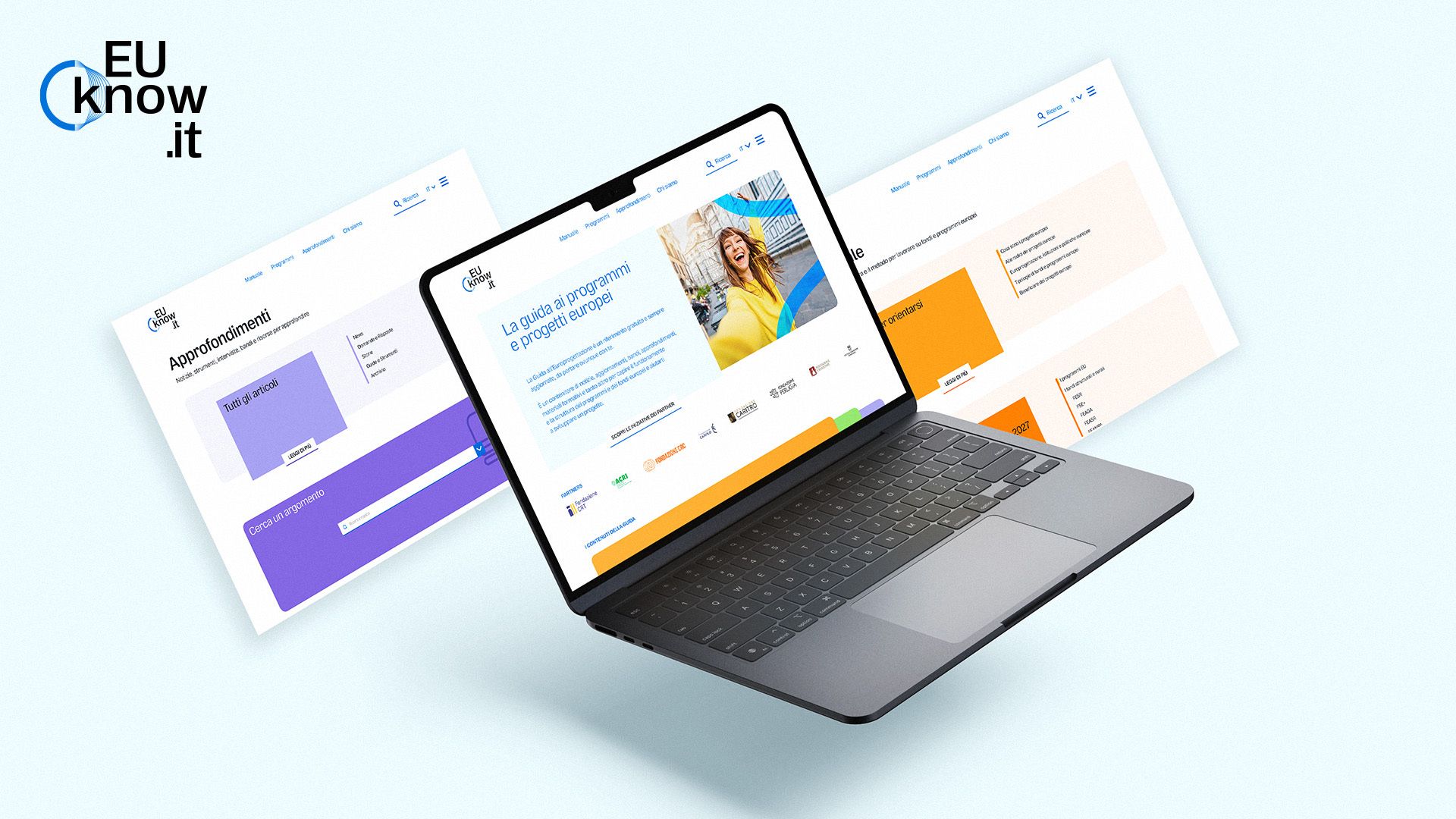
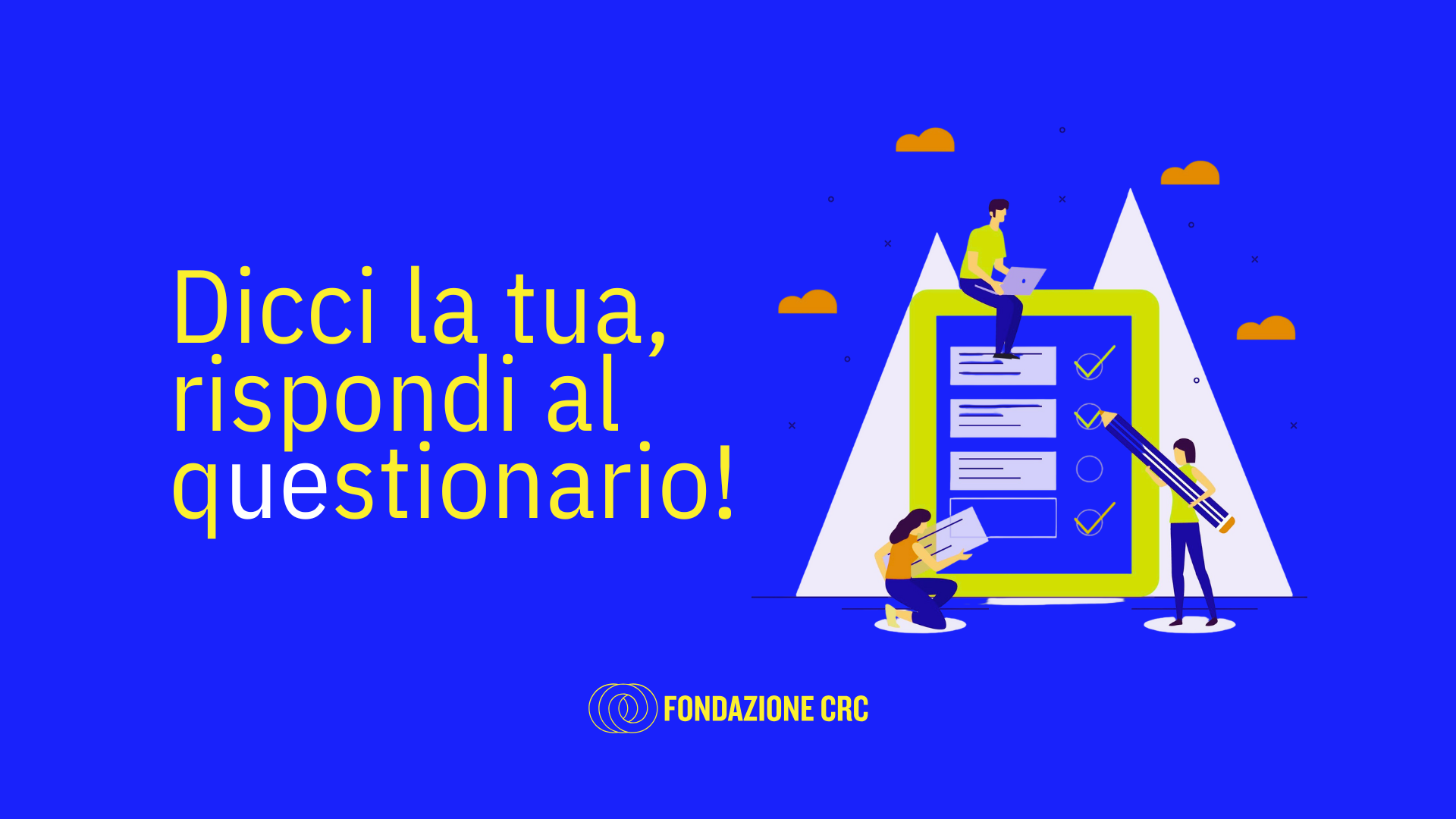





















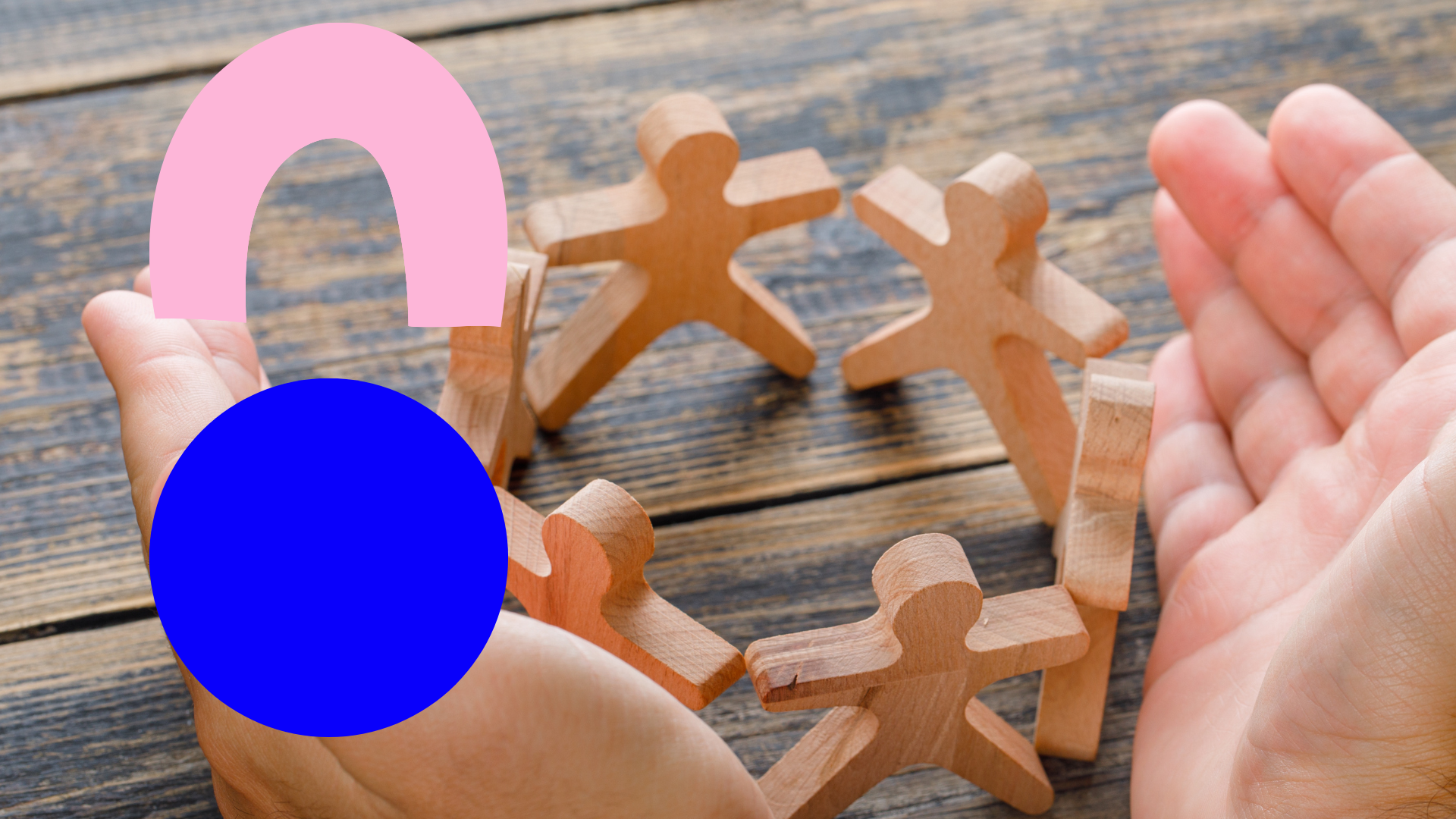
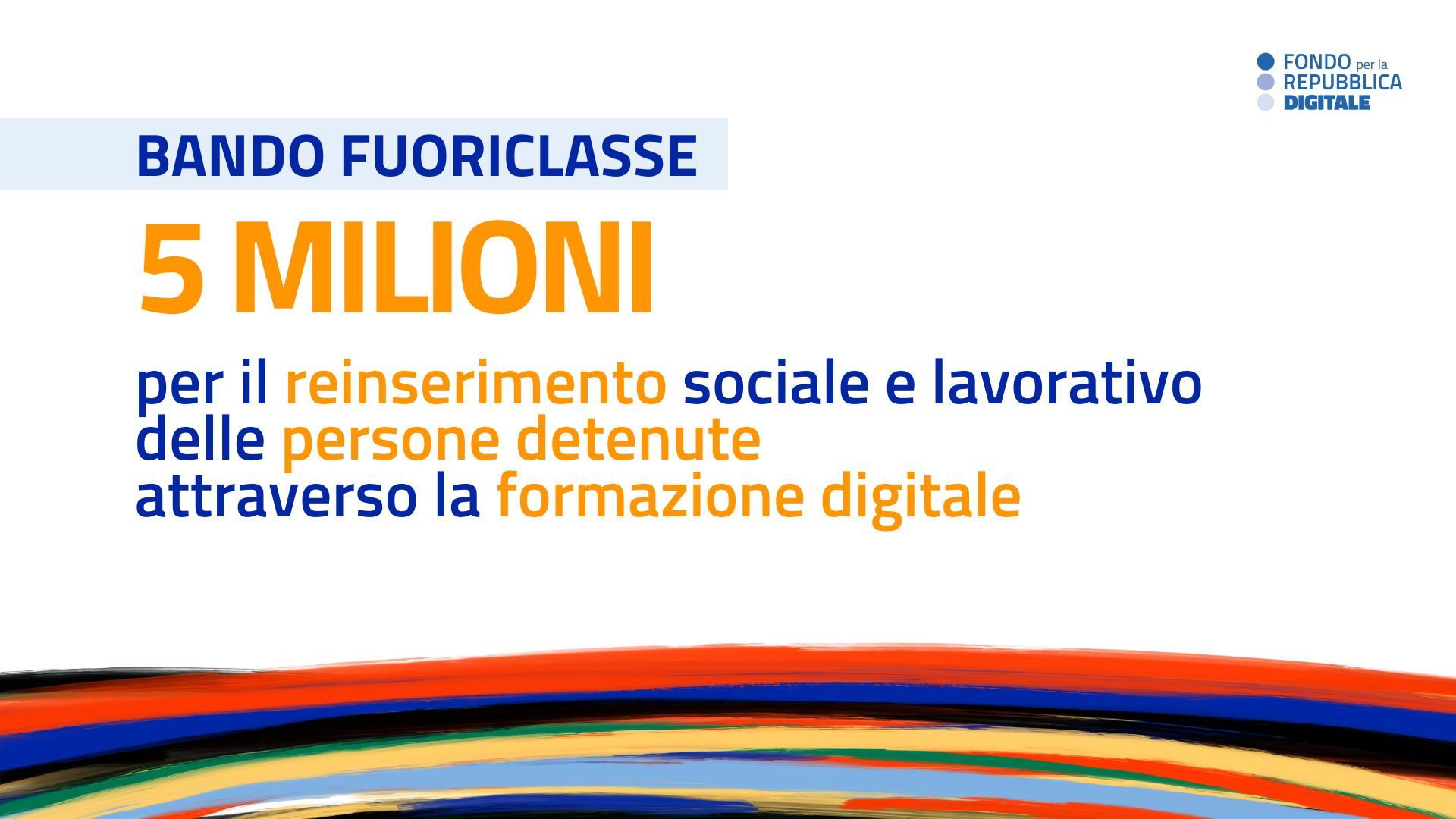






 Fondata nel 2014, nel corso degli anni Kalatà ha intrapreso un percorso di trasformazione. In un panorama di offerte turistiche tradizionali, con guide che illustrano e visitatori che ascoltano, Kalatà ha deciso di cambiare prospettiva, proponendo esperienze di visita molto più immersive, anche grazie ad un linguaggio più accessibile e coinvolgente.
Fondata nel 2014, nel corso degli anni Kalatà ha intrapreso un percorso di trasformazione. In un panorama di offerte turistiche tradizionali, con guide che illustrano e visitatori che ascoltano, Kalatà ha deciso di cambiare prospettiva, proponendo esperienze di visita molto più immersive, anche grazie ad un linguaggio più accessibile e coinvolgente.
























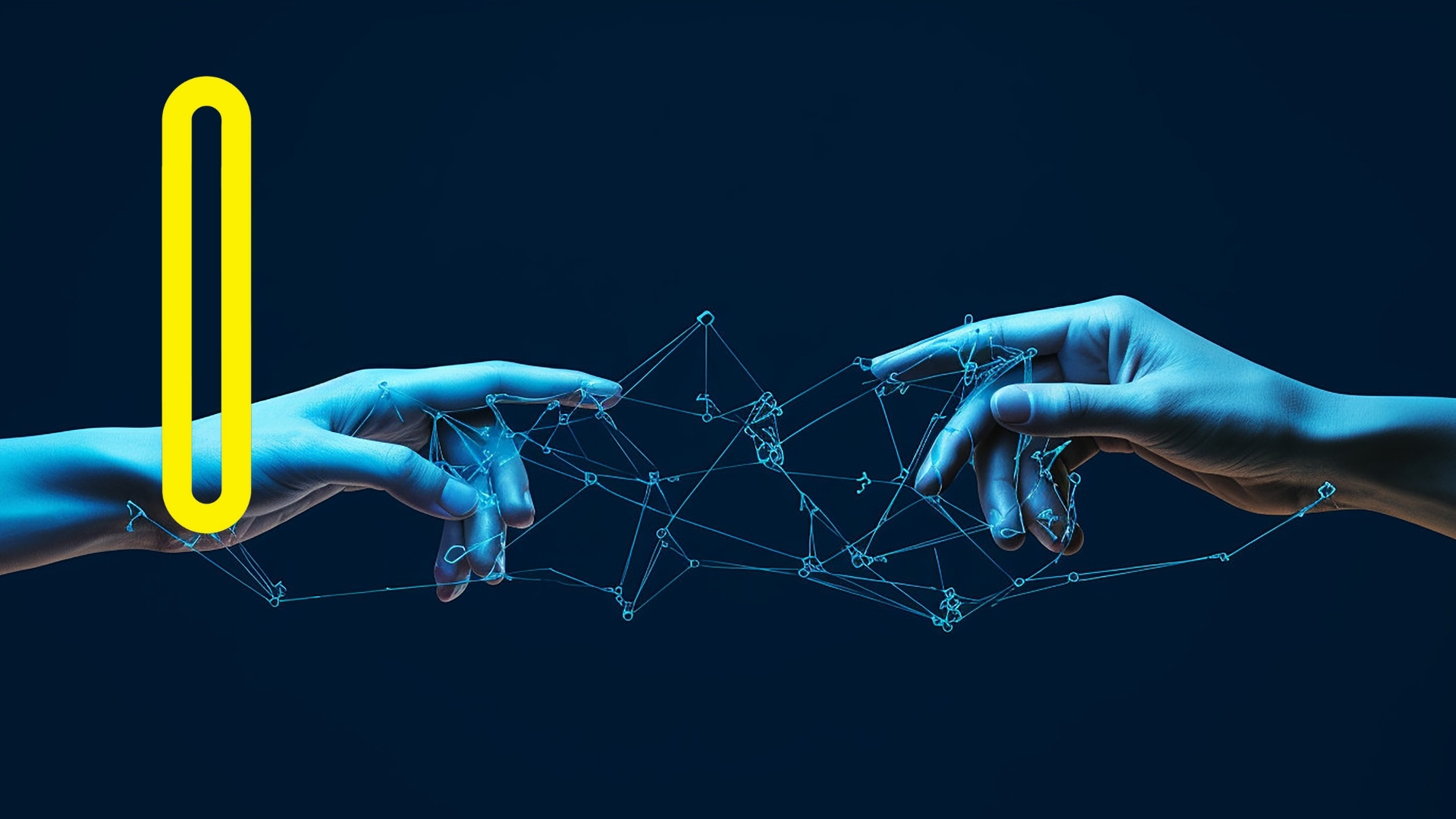
 progetto
progetto 






 di trovare una targa che riporta “realizzato grazie al contributo di INTERREG”, con il logo dell’Unione Europea.
di trovare una targa che riporta “realizzato grazie al contributo di INTERREG”, con il logo dell’Unione Europea.






